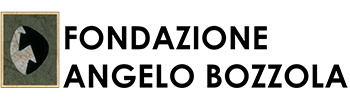L’ARMONIA DELLA FORMA. Angelo Bozzola e il Movimento Arte Concreta (1948-1958)
L’ARMONIA DELLA FORMA. Angelo Bozzola e il Movimento Arte Concreta (1948-1958)
a cura di Chiara Gatti
REAZIONI A CATENA. Angelo Bozzola e il MAC
«Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell’uomo scoprire per il bene dell’uomo stesso e la gloria del Creatore».
Gregor Johann Mendel
«Dunque all’antichissimo concetto di divisione netta dei corpi, al più moderno concetto impressionista di suddivisione, di ripetizione, di abbozzo delle immagini, noi sostituiamo il concetto della continuità dinamica come forma unica».
Umberto Boccioni, Pittura e scultura futuriste, 1914
Diceva Pablo Picasso che «l’arte astratta non esiste. Bisogna iniziare sempre da qualche cosa». Per Angelo Bozzola, in principio era la natura. «La mobilità e mutabilità dei regni animale e vegetale» scrisse in un appunto steso di getto – breve ma precisissimo – intorno alla metà degli anni Cinquanta. All’epoca, il suo legame col Mac era già siglato. Nel 1954 entrò a fare parte del gruppo milanese, sostenuto da uno dei fondatori, Gianni Monnet che, l’anno seguente, firmò anche il testo introduttivo per la sua personale alla Galleria del fiore di Milano.
Passando in rassegna le opere di inizio decennio, si capisce come Bozzola fosse arrivato in fretta a un’idea di forma affine a quella teorizzata dai colleghi concretisti. Astratta, ma mai puramente geometrica, esito solo di calcoli esatti. Al contrario: pulsante, primordiale, germinativa. Una forma ancestrale, estratta dai meandri della memoria e sublimata dalla sintesi assoluta dei ritmi, delle tensioni. In una parola, vitale.
C’è vita, infatti, e c’è natura nella serie delle opere del 1953 che intersecano grandi ellissi come fossero foglie di loto. Sovrapposte, l’una sull’altra, suggeriscono un gioco di profondità, di piani alternati. Tutto era nato da una prima scultura embrionale che suggeriva la genesi di un frutto. Una corolla di ferri, di ritagli d’officina, lanceolati come petali, si dischiudeva mostrando un cuore duro, un sasso custodito come un nocciolo. Bozzola giocò ampiamente sull’immagine di un fiore maturo, pronto a trasformarlo in una metafora della creazione, un’epifania della forma compiuta. Gli studi a matita e pastello colorato di quell’epoca, ma soprattutto un dipinto a olio, all’apparenza ingenuo, emerso dai suoi archivi, tradiscono un processo mentale logicissimo. L’origine del suo pensiero concreto. E proprio Concreto s’intitola infatti quest’opera programmatica, orchestrata attorno a un bulbo, che ricorda bene la pietra naturale della sua sculturina gemella e che spalanca nell’aria le sue lamine colorate. L’iconografia rimanda senza dubbio a una soggetto biologico e tradisce la memoria dei fiori futuristi e sintetici di Giacomo Balla, petali sezionati come fiamme dentro un vaso ridotto a uno stelo geometrico, apparizione dell’idea del fiore, più che una sua descrizione naturalistica.
Gillo Dorfles, nel suo testo del 1951, sugli artisti del MAC, pubblicato a corredo della mostra alla Galleria Bompiani, parlò di un “primus movens” – il “motore immobile” di Aristotele – riferendosi a un modulo grafico «che può svilupparsi da un ghirigoro, da un segno elementare, che può derivare da un impulso dinamico non perfettamente cosciente e razionalizzato». Da tale modulo si sprigiona una catena di cause ed effetti che non dimentica mai il suo principio vitale, il suo “progenitore”, per citare ancora Dorfles. «Potremmo veder affiorare – scriveva in chiusura – la forma ameboide d’una cellula, gli aspetti di strane strutture organiche o minerali. Potremmo assistere cioè alla proiezione di archètipi formativi restati a lungo inutilizzati, e che oggi riappaiono, diventando i generatori di nuovi spunti plastici».
La differenza con le altre forme di poetica astratta, dominanti nel secondo dopoguerra, è palpabile. Per gli autori del MAC, tanto quanto per Bozzola, la scintilla innescata dal mondo reale – seppure primigenio – era determinante. Un retaggio tipico lombardo, se si pensa alle disquisizioni storiche di Roberto Longhi sulla vocazione alla natura dei grandi maestri padani e sul segreto lirico dell’arte lombarda tout court, «un’arte concreta, fatta di fiducia terrena e scevra di ogni allucinamento». Concreta, già a detta di Longhi! E terrena, nel senso del suo debito verso un humus arcaico che, non a caso, torna nelle riflessioni di Bozzola, laddove egli specificava che la sua arte non era volta a trascendere la vita, ma era sempre, in qualche modo, connessa a realtà sociali o naturali. «Composizioni – stabili, mobili, flessibili, vibranti – chiaramente e intenzionalmente coerenti alla mobilità del regno animale, alle vibrazioni del regno vegetale, allo sforzo costruttivo della natura, quale vediamo negli spaccati geologici e nella stratigrafia tettonica».
Elena Pontiggia, in un recente saggio dedicato a Bozzola in occasione dell’ultima mostra alla Triennale di Milano, ha evidenziato le origini colte della sua ricerca. Il rapporto antichissimo fra osservazione del dato naturale ed elaborazione di una regola, fra misura fisica e proporzione ideale, fra accadimento e ordine universale. Una prospettiva quattrocentesca digerita e assimilata dall’artista di Galliate che giunse, proprio in virtù di questa codificazione della realtà sensibile, alla edificazione del suo celebre “modulo”; una formula, un’unità, un canone su cui erigere volumi complessi, ma in ogni circostanza disciplinati da equilibri armonici. Come in architettura. O come in quella stessa fisica organica a cui Bozzola e, prima di lui, Dorfles, alludevano nei loro scritti.
Questo spiega le ragioni estetiche delle cellule ameboidi (vagamente surrealiste) di Radice, delle fantasie genetiche di Monnet, delle vegetazioni lunari di Soldati, dei germi di grano di Reggiani, dei frattali di Munari o dei baccelli di Bozzola legati, in sottotraccia, alla lezione di Nino Di Salvatore, direttore del Centro studi arte-industria, risposta novarese al Bauhaus di Gropius, la mitica scuola tedesca di progettazione, epicentro della rivoluzione intellettuale nell’Europa degli anni Venti. Di Salvatore sosteneva infatti, come i colleghi fondatori del MAC, che la creazione estetica avesse radici profonde «nel mondo psichico, fisico, biologico e dalla natura inorganica» dimostrate da analogie evidenti «fra una forma tipica concreta e certi aspetti del mondo dell’embriologia, dell’istologia, della fisica nucleare, della botanica, della zoologia». Un universo microscopico che l’artista poteva non aver osservato con occhio scientifico, ma che gli apparteneva intimamente, inconsciamente, incistato nel suo substrato genetico.
L’evoluzione della forma nelle ricerche di Angelo Bozzola, a partire dai disegni ovulari del 1952, ma soprattutto nella Rappresentazione concreta del 1954, capolavoro di sintesi armonica, dichiara questa relazione con la gestazione della vita in natura, con un metabolismo basale, con la biologia di uno sviluppo in cui l’ellissi partorisce il quadrato. La forma è come una placenta che custodisce una geometria palpitante. Si potrebbe parlare di una mutazione moderna delle teorie vitruviane sulle proporzioni ideali del corpo umano, armoniosamente inscritte nelle figure perfette del cerchio e del quadrato, secondo il leggendario studio leonardesco, in questo caso virato verso una indagine sulla forma in quanto tale. Infatti l’investigazione di Bozzola sul significato della forma pura oscilla fra la soglia della ricerca cellulare e una verifica naturalistica delle dinamiche dei corpi. Non per nulla emerge un gancio palese con le riflessioni del futurismo italiano, di Balla e Boccioni in particolare, e con la loro volontà di penetrare la visione, fino a scovarne la regola.
Il livello scientifico a cui giunsero le speculazioni dei padri teorici dell’avanguardia trova un compendio stimolante nella Struttura di elementi mobili o nella Struttura architettonica con posizioni variabili, in cui Bozzola pare recuperare la scissione della materia operata dall’apporto della luce e del moto nelle immagini dei futuristi, proiettandole in una dimensione più astratta. Liberandosi cioè dall’ormeggio figurativo, dalla famosa mano del violista di Balla, dalle zampe del cane al guinzaglio, per approdare alla sintesi totale del triangolo e del cerchio, poi della spirale e della catena nei moduli che si scompongono nell’aria, come l’elica del DNA.
Accostando le diverse “composizioni concrete” di Bozzola del 1954 ai modelli futuristi basati sulle “linea della velocità”, sui “dinamismi” o le “compenetrazioni”, si nota la capacità dell’autore di traghettare le conquiste dei maestri verso una nuova sperimentazione formale che rispecchiava anche un panorama culturale aggiornato alle ricerche scientifiche del tempo. Per i futuristi si trattava di macchine e motori, di elettricità e velocità. Per Bozzola, si parla dei miraggi della corsa allo spazio, del boom della tecnologia, delle scoperte scientifiche all’alba della contemporaneità. Una prospettiva ancora più tecnica da un lato, ancora più biologica dall’altro, che non poteva non riflettersi nelle sue «iterazioni», come aveva battezzato i suoi studi sul perpetuo divenire delle cose.
Inutile ricordare che, giusto nel 1953, Watson, Crick e Wilkins pubblicarono e diffusero la loro scoperta della struttura a doppia elica del DNA. E che nel 1957 i russi spedirono nello spazio la prima capsula, seguita subito da una seconda con a bordo la povera Laika. I misteri del cosmo, così come quelli del corpo, si aprivano agli occhi degli artisti pronti a nutrire un immaginario astrale. Angelo Bozzola entrò allora nella fase lunare delle sue “funzioni”; tagli geometrici, colori dinamici, giustapposizioni e incastri a tinte diverse evocavano onde radar e interferenze. Schegge di triangoli affilati saettavano fra padiglioni e dischi circolari mentre, da una porzione della sua ellissi irregolare sbocciavano i primo moduli. Era la metà esatta degli anni Cinquanta. Gli amici del MAC stavano sperimentando figure geometriche sempre più semplici e schiette: quadrati, losanghe, trapezi. Manlio Rho costruiva le sue scacchiere di rettangoli intrecciati come i tessuti di vimini. Regina (la signora del futurismo ritrovatasi concretista) ritagliava collage perfetti di poligoni affilati come i raggi delle stelle. Enrico Prampolini non rinunciava al fascino fluido delle onde, memoria superstite delle sue sintesi cosmiche, anch’esse d’epoca futurista.
Angelo Bozzola issò le prime pietre solide di un edificio architettonico inalterabile nei suoi elementi morfologici. Nei diversi studi su carta, così come nelle grandi tele a olio, simili a manifesti di una poetica personale, i corpi si scindevano e ricomponevano come fanno gli elettroni negli atomi. «Mutazione estetico/naturalistica» la battezzò. Una tavola progettuale in cartoncino bianco del 1959 spiega bene il processo mentale cui era arrivato negli anni di maggiore collaudo e verifica della formula. Da una matrice rettangolare piana si ritagliava il modulo ovoidale e lo si attraversava con tracce misurate che rappresentavano fratture e piegature spaziali, tagli dinamici utili a proiettare la forma dalla bi-dimensione alla terza dimensione. Un disegno reso plastico. Volumetrico. Da esso, poteva, di conseguenza, generarsi una catena componibile, regolare, moltiplicata. «La progressione del modulo nello spazio» derivava, insomma, dalla moltiplicazione (per n. volte) della sua «monoforma piana trapezio-ovoidale». E viene ancora in mente Balla quando, parlando delle linee-forza della velocità e del moto – riferendosi alla famosa Bambina che corre sul balcone – diceva «le gambe si scompongono in linee triangolari, mentre la sintesi dell’azione è data da segni curvi in successione: tutto si astrae con equivalenti che, dal loro punto di partenza, vanno all’infinito».
La descrizione naturalistica genera l’apparizione dell’idea e, in un certo senso, soccombe ad essa. Alla base del ragionamento di Bozzola si legge il portato dell’avanguardia storica, ogni sfumatura di quei concetti di “dinamismo” e “compenetrazione” sposati ora alla nozione rivoluzionaria di spazio varata da Lucio Fontana nel 1947 con la serie dei “buchi” sulla tela e poi (proprio dopo la metà degli anni Cinquanta) con i suoi “tagli”. Fontana, nel 1948, partecipò alla prima cartella di Arte Concreta, presentata dalla Libreria Salto di Milano, con una stampa animata da un grumo di bolle aggregate come particelle, organismi uniformi. Bozzola valutò l’ipotesi parallela di rendere seriale il suo modulo, aggregando a sua volta ogni monoforma in concatenazioni variabili, in sequenze libera, «date con la massima elasticità spaziale» dichiarava. Stupisce il rigore con cui l’artista perseguì la sua ricerca con coerenza, passando dal linguaggio della pittura a quello della scultura senza soluzione di continuità.
E veniamo allora alla scultura. Medium nel quale il suo pensiero si manifesta ancora più logico.
Il grande scrittore e filosofo dell’illuminismo tedesco Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), nel suo celebre saggio sull’estetica intitolato Laocoonte, concentrato sulle grandi differenze fra pittura e poesia, giunse a definire la scultura come “un dispiegamento dei corpi nello spazio”. Come qualcosa segnato da precise proprietà visibili, cristallizzate però nel tempo, per via della loro natura statica e della loro materia inerte. Inutile dire che Lessing, mente lungimirante e perspicace, intuì, fra le righe, una linea evolutiva della forma che l’avrebbe portata, in un “certo” futuro, a dimostrare la sua vitalità, la sua capacità di perdurare nello sguardo dei posteri come un oggetto ogni volta diverso e sorprendente. Pronostico azzeccato. A distanza di un secolo dalle sue riflessioni, l’arte moderna cominciò a interrogarsi sui valori dell’esperienza temporale e a combattere la sua battaglia contro la fissità dell’immagine. La storia della scultura moderna, da Rodin a Medardo Rosso, fino naturalmente allo stesso, indimenticabile Boccioni, lo dimostra. E la storia personale di Bozzola, nel momento in cui l’artista incontrò i valori espressivi dell’acciaio, segue a ruota il lascito dei maestri.
Quando nel 1956 issò un suo piccolo, fragile modulo su uno stelo di ferro, lungo, sottile e vibrante nell’aria (derivato, verosimilmente, da un analogo motivo dipinto su tela l’anno precedente), era chiaro che la sua attrazione per il tema della forma dinamica avesse preso ormai una direzione precisa e che, la scultura, lo avesse aiutato a siglare definitivamente il suo concetto di visione e composizione. «Noi sostituiamo il concetto della continuità dinamica come forma unica» dichiarava Umberto Boccioni fra le pagine di Pittura e scultura futuriste. La forma unica per Bozzola era il suo modulo. La continuità dinamica la ottenne dispiegandolo nello spazio come i “corpi” di Lessing. Nacquero così successioni auree di ovuli rotanti, imbrigliati fra loro da lacci flessuosi e duttili, in grado di dipanare nastri nel vuoto e di riavvolgerli in una unità di base, preesistente.
L’aspetto ludico del gioco di costruzioni lineari, già dichiarato per esempio da un mobile policromo in plexiglas del 1954, e affine alla poetica delle sculture aeree di Munari, forse ispirate proprio da una intuizione di Bozzola, andava di pari passo con la dimostrazione pratica di un enunciato astratto. La materia applicata all’essenza dell’idea rendeva tutto esplicito. Lo si capisce dalla grande Rappresentazione del 1955, in acciaio inox speculare. Essa appartiene alla serie delle “funzioni/sviluppo di forma concreta”, di cui Bozzola realizzò altri esemplari coevi in ferro verniciato nero. Qui il suo trapezio-ovoidale apre le ali all’atmosfera palpitante intorno. Un dispiegamento della superficie al vento, dentro la profondità di una prospettiva aumentata anche dal valore riflettente dell’acciaio. «Elemento indispensabile dell’uomo e congeniale all’attuale società» scriveva nei suoi taccuini.
Anche quella che lui definiva «la polimateria» contribuì allo scopo di moltiplicare le sue strutture modulari con effetti cangianti. In una Biforma e in un’altra Struttura, entrambe del 1958, gli elementi si articolavano nel ferro e nelle fusioni d’ottone, fra lastre lucide e altre spalmate di cemento. Il dialogo fra il bianco e il nero, il liscio e il ruvido, il concavo e il convesso acuiva il senso di duttilità e vitalità della materia. Le «vibrazioni del regno vegetale» e lo «sforzo costruttivo della natura», «spaccati geologici» e «stratificazioni tettoniche» cui si accennava prima, prendevano forma fra le sue mani di carpentiere raffinato, attento a trasferire nelle progressioni plastiche dei moduli i criteri scientifici che stavano, a suo giudizio, alle origini della visione, della percezione delle cose agli occhi dello spettatore, cui l’opera poteva (o doveva) rivelare qualcosa di più sui misteri della realtà.
Dorfles, nel testo del 1951, sembrava aver presagito gli sviluppi cui era destinata la riflessione del MAC. Una riflessione puntuale «sia che la mano tracci un segno preso a prestito a un elemento reale (ma non però copia d’oggetto naturalistico), sia che si valga di alcuni schemi formali sempre ricorrenti e che, a mio avviso, si possono considerare come progenitori d’ogni espressione grafica, conscia od inconscia». Nel caso di Bozzola, più conscia che inconscia. Complice il suo carattere determinato, volitivo, la cura con cui stendeva progetti e prototipi, siglò ogni volta opere che erano il risultato di un procedimento analitico. Basti pensare alla sequenza creativa della Funzione-sviluppo di forma concreta del 1955, fatta di studi a matita, china, matrice a linoleum e relativa stampa, prima di approdare alla realizzazione plastica in ottone. Con spirito tecnico e ordine logico dipanava algoritmi grafici, pronto anche a testarne le modificazioni cromatiche nelle serie delle “strutture” del 1958, innescando reazioni a catena dovute al cambio di un tassello, all’inversione di uno spigolo, al cortocircuito fra tonalità complementari.
Talvolta Bozzola cadeva nell’ossessione della forma e della sua propagazione nello spazio, arrivando a moltiplicare in modo quasi tachicardico i frammenti estratti dall’ovulo. Altre volte manteneva saldo il controllo del ritmo e di quella ideale unità boccioniana, raggiungendo esisti di straordinaria leggerezza. Come nella monumentale Funzione-sviluppo di forma, matrice modulo, del 1958, dove il registro orizzontale genera e stilla verso l’alto un nastro di ferro agile, sintesi estrema di un percorso mentale, partito da un nucleo compatto, un nocciolo duro e pieno della materia, pronto a scindersi in frammenti – come nella fissione nucleare! – e a produrre energia nello spazio che le frulla intorno. Il teorema di Bozzola, all’epoca del MAC, fu la «sofferta e gioiosa conquista di una “forma” personale» archetipo, cellula, embrione di una ricerca sui meccanismi della visione e sull’ossatura del visibile che lo avrebbe portato, negli decenni seguenti, conclusa l’avventura del MAC, verso nuovi e fecondo campi di indagine.